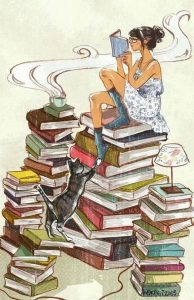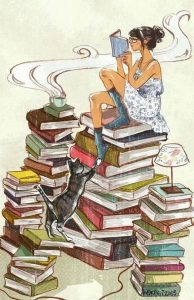
La cultura, nel linguaggio di senso comune, è l’insieme di nozioni che l’uomo acquisisce attraverso lo studio o attraverso l’esperienza. In poche parole, la cultura è associata all’erudizione: “è colto colui che sa”
Però, è anche vero, che il concetto di cultura ha subito delle modificazioni nel tempo. Oggi non viene, semplicemente, considerato colto colui che sa, ma colui che riesce a interpretare in modo profondo e originale tutto quello che ha a disposizione. Quindi è grazie a questa personale “manipolazione” che, ognuno di noi, si costruisce una propria personalità intellettuale, morale ed estetica.
In realtà, secondo l’antropologia culturale, ha un significato che va ben oltre il senso comune ed il possesso individuale di un’erudizione più o meno rielaborata. Il concetto di cultura risulta essere, indubbiamente, quello più discusso e controverso nella storia del pensiero antropologico. Ne sono state elaborate innumerevoli definizioni, ma la prima definizione in senso antropologico del concetto è stata delineata nel 1871 dall’antropologo evoluzionista Edward Burnett Tylor che così definisce : “La cultura o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità o abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro di una società”. La definizione di Tylor è il punto di riferimento classico dell’antropologia culturale. Punto di riferimento cronologico, perché il 1871 è la data di nascita della disciplina; punto di riferimento logico, perché quella definizione si offre a precisazioni, riformulazioni, ampliamenti o restringimenti. L’espressione “insieme complesso” sottolinea uno degli aspetti più importanti della definizione tyloriana: il mescolare. Il costume è messo insieme alla conoscenza, all’arte, alla morale ecc. e il “qualsiasi altra capacità…” spiega qual è l’elemento che le parti della cultura hanno in comune e giustifica il mescolamento: come il costume, la conoscenza, il diritto ecc. che non vengono trasmessi geneticamente ma acquisiti socialmente. La definizione supera la separazione in classi, ceti o strati sociali; la cultura non emerge da alcuni ambiti esclusivi di attività intellettuale, propri di alcuni ceti sociali, e neppure, ampliando il concetto, è appannaggio esclusivo di alcune società, in opposizione a quelle che, proprio perché ritenute prive di cultura, venivano relegate all’ambito della natura, erano cioè società selvagge. Essa, “intesa nel suo ampio senso etnografico” accomuna tutte le società umane (così come tutti i livelli interni a una società). Questa accezione apre la via alla riflessione antropologica: perché sancisce che la cultura è una caratteristica dell’uomo sociale in quanto tale, quale che sia il luogo in cui si trova e il modo in cui si è organizzato. La cultura è qui, da noi, come in qualsiasi altro luogo, presso gli altri. Da ciò deriva l’importanza del viaggio etnografico, del viaggio verso forme diverse di cultura.
La concezione pragmatica, invece, presenta la cultura come formazione individuale, volta all’esercizio di acquisizione di conoscenze “pratiche”. In tale accezione essa assume una valenza quantitativa, per la quale una persona può essere più o meno colta.
La concezione metafisica, al contrario, presenta la cultura come un processo di sedimentazione dell’insieme patrimoniale delle esperienze condivise da ciascuno dei membri, delle relative società di appartenenza, dei codici comportamentali condivisi, del senso etico del fine collettivo, e di una visione identitaria storicamente determinata, come espressione ecosistemica di una tra le multiformi varietà di gruppi umani e civiltà nel mondo. Concerne sia l’individuo, che i grandi gruppi umani, di cui egli è parte. In questo senso il concetto è ovviamente declinabile al singolare, riconoscendosi ciascun individuo quale membro “di diritto”, del gruppo etno-culturale di appartenenza etno-identitaria, nonché nel “patto di adesione sociale” e nelle sue regole etiche ed istituzionali volte al fine della “autoconservazione” del gruppo etnico stesso.
La concezione di senso comune è, inoltre, il potere intellettuale o “status”, che vede la cultura come luogo privilegiato dei “saperi” locali e globali, tipico, delle istituzioni “superiori”, come le “conoscenze specializzate”, la politica, l’arte, l’informazione, l’interpretazione storica degli eventi, ma anche l’influenza sui fenomeni di costume, e sugli orientamenti, delle diverse popolazioni, fino a livelli di misura planetaria.
La concezione di tipo istituzionale, infine, vede la cultura come strumento di formazione di base e di preparazione al lavoro nell’ordine di una società economica, meritocratica e delle competenze remunerabili.
Mi ha colpito, nel mio “vagare culturale”, una citazione di un papà:
Ho sognato di chiedere a mia figlia di disegnare la cultura e lei ha disegnato una giostra con tanti bambini. Io, che invece avrei disegnato un’immensa libreria, le ho chiesto perché, lei mi ha risposto “Babbo, sei tu che dici che la cultura è quella magia che ci fa stare tutti insieme!”
Forse l’innocenza infantile è in grado di vedere oltre, dove la mente di un adulto non riesce ad arrivare.
Anche questa è cultura!
“Liberamente tratto da varie fonti”